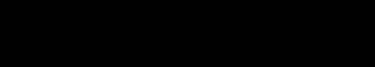Antonio Marras e la Sardegna che non finisce mai
In occasione di BIT 2026, lo stilista racconta la sua terra in una intervista a X Style, come crocevia di popoli e “somma di tracce”, non cartolina ma stratificazione viva. Dall’idea di artigianato in continua evoluzione al legame fondativo con Maria Lai e alla mostra Paso Doble, fino alla collezione PE 2026 del suo marchio che innesta frammenti autentici del costume sardo nel presente, ma senza effetto museo. Un manifesto di identità, libertà e ossimoriDi Giuditta Avellina
Alla BIT 2026 di Milano - la Borsa Internazionale del Turismo - tra mappe luminose e promesse di “destinazioni”, Antonio Marras sposta subito il baricentro. Non parla della sua Sardegna come di un luogo da consumare, ma come di un territorio che osserva, che stratifica. “La Sardegna può essere spunto straordinario ed essere veramente fonte inesauribile di incontri e di scoperte”, racconta a X Style. E subito dopo affonda nella geografia che diventa storia: “Siamo al centro del Mediterraneo. Tutti sono arrivati in Sardegna. Tutti hanno lasciato delle tracce”. Tracce è la parola chiave. Perché l'idea di identità dello stilista e creativo non è mai purezza, è somma. “Noi siamo veramente la somma di questi popoli.” E dentro questa somma c’è un mistero che resiste: “Una terra disseminata di abitazioni strane che si chiamano nuraghi e che ancora sono un grande mistero”.
L'alfabeto della moda che parte dalla Sardegna
Per Marras la moda non è tema, è sistema di segni. Un alfabeto che dialoga con arte, musica, teatro, cinema. E dentro quell’alfabeto scorre un filo rosso - in sardo ligazzio rubio - che tiene insieme tutto. “Chi nasce su un’isola ha sempre una necessità: il bisogno di andare restando.” È la frase che lo definisce. L’insularità non è nostalgia ma tensione. Anche il mare, dal punto di vista di Marras, cambia senso: “Ho sempre pensato che il mare non fosse un limite, il mare per me è stato una strada.” Lo racconta con un’immagine semplice: i traghetti, le valigie, la cena portata da casa. Partire senza sentirsi in fuga. Sapere che si può tornare. È lo stesso principio che regge il suo negozio di New York, al 121 di Wooster Street, nel quartiere di SoHo. “Io nasco in negozio. Ho sempre pensato che il negozio fosse la replica della mia casa.” L’accoglienza come grammatica sarda anche a migliaia di chilometri di distanza. Divani, libri, una grande serra finale: non retail ma attraversamento. Anche lì, "andare restando".

L’artigianato come evoluzione, non reliquia
“Ho delle mani rubate alla terra, quindi mi sento profondamente artigiano. L’artigianato non è una cosa statica, ferma, ma in continua evoluzione.” Sughero, ferro, ceramica non sono folklore ma cultura e l’isola dialoga da sempre con ciò che sta oltre. Dentro questa linea si inserisce Maria Lai. Non l’artigiana in senso decorativo, ma l’artista che ha trasformato fili e cuciture in pensiero visivo. Il dialogo tra loro trova forma nella mostra "Maria Lai | Antonio Marras: Paso Doble" alla M77 Gallery di Milano, curata da Francesca Alfano Miglietti: circa duecento opere in confronto serrato. Non un omaggio, ma un passo a due tra linguaggi affini. Qui il discorso diventa personale. Maria Lai non è un riferimento culturale: è un’origine. È la frase che chiude l’intervista a renderlo esplicito: lei “mi ha visto nascere bambino e diventare uomo”. Prima delle passerelle, prima di Parigi, prima dell’America, c’era quello sguardo.

L’ossimoro come estetica
Marras inventa una parola: “ossimoroso”. Gli serve per definire la sua terra, “ricca di contrasti… cose talmente lontane ma che possono toccarsi, amalgamarsi, fondersi”. È la sua estetica. Il lontano che non si annulla. Il passato che entra nel presente come innesto, non come travestimento. Ed è così in ogni sua collezione e la Primavera-Estate 2026 è stata una ennesima prova narrativa. Una Sardegna evocata, letteraria, con figure come Frieda von Richthofen e D.H. Lawrence che sembrano approdare ad Alghero. Ma il gesto tecnico è più radicale: alternare capi nuovi a frammenti autentici di costumi tradizionali, “troppo belli per essere rivisitati, troppo importanti per non essere condivisi”.
Quando arrivano ricami e parti originali, rifiuta la replica: “Ho pensato che sarebbe stato sciocco riprodurli, ho solo provato a prendere questi pezzi.” Li porta in atelier a collezione già costruita, li stende sui tavoli, li combina, li sconvolge. E quando il pubblico non distingue più cosa è antico e cosa è nuovo, legge lì il successo dell’innesto: “La gente pensava che quelli erano i ricami della collezione mia. Questo vuol dire che siamo riusciti a innestare nella maniera più giusta elementi veramente del passato.” Poi c’è l’interno dell’abito: “Mi piaceva l’interno anziché l’esterno… quei segni, quei fili, quelle tracce… sono molto spesso più belle.” Vale per la moda, vale per l’isola.

Quaranta centimetri di libertà
Alla fine resta un’immagine. Il promontorio di Capo Caccia come gigante che dorme. La spiaggia della Speranza. E un rigagnolo largo quaranta centimetri che segna un confine tra due comuni. Lui lo attraversa sempre. “Io odio i muri, i confini. Amo passare da una parte all’altra, in assoluta libertà.” È questo il gesto che riassume tutto. Non un’identità da esibire, ma un movimento continuo. Andare restando. Cercare l’altrove senza perdere la radice. Tenere insieme gli opposti finché, con lui e dentro lui - è la magia dell'arte e della moda in fondo - smettono di esserlo.

Contenuti consigliati
- lifestyle
Antonio Marras e la Sardegna che non finisce mai
In occasione di BIT 2026, lo stilista racconta la sua terra in una intervista a X Style, come crocevia di popoli e “somma di tracce”
- lifestyle
Le biblioteche più belle al mondo da segnare per il prossimo viaggio
Sono luoghi magici in cui rifugiarsi, dove conoscenza, arte e bellezza si uniscono
- fashion
Slingback primaverili 2026: le più belle da indossare in ogni occasione
Con i jeans per un twist cool, sotto i tailleur per l’ufficio o abbinate ad abiti e gonne midi per la sera
- living
San Valentino 2026: l’amore si regala (e si gusta)
Dai cuori di cioccolato alle colazioni per due, dalle creazioni d’autore alla Love Box con caviale
- fashion
Sposa a primavera, il dettaglio insolito per essere diverse
Quali accessori scegliere per un abito che si distingua dal solito abito
- entertainment
Il video di Malinin sul ghiaccio da bambino. Ecco gli inizi del “primo uomo sulla luna”
Il 21enne considerato il pattinatore di figura più bravo al mondo si prepara alla gara più importante delle sue Olimpiadi
- fashion
Denim prezioso: giacche e jeans con cristalli per look effetto bling-bling
Dalle silhouette sartoriali ai dettagli scintillanti effetto degradé, il denim della primavera 2026 si illumina con strass e cristalli
- fashion
New York Fashion Week FW2627: come Ralph Lauren con Gigi Hadid riscrive i codici dell’abito da sera
La top statunitense dimostra ancora una volta la sua capacità di stravolgere le regole dello stile
- living
Olimpiadi invernali 2026: aperitivi, cocktail e après ski a tema da provare a Milano
Tra rooftop, cocktail bar e chalet urbani, Milano racconta i Giochi attraverso la mixology
- beauty
Fragranze, oli e hair mist: tre gesti profumati per celebrare San Valentino
Indossati da soli oppure mixati, per un mélange originale, creano un sillage davvero irresistibile
- fashion
Tutti i colori dei cappellini con visiera, ecco i modelli da indossare
Dalle tonalità scure a quelle calde e terrose, fino alle tinte accese e alle fantasie più originali: i baseball cap sono fra gli accessori più versatili da inserire nel guardaroba. Parola di star, di ieri e di oggi
- entertainment
Jutta Leerdam non è solo un oro olimpico, ma anche icona di stile e regina social
A Milano Cortina 2026 l'olandese conquista l’oro nei 1000 metri di pattinaggio velocità e si consacra icona globale
- fashion
Mantelle: il classico regale in chiave urban da comprare per la primavera
Dal minimalismo del bianco alle fantasie stampate, le mantelle tornano a dominare il guardaroba femminile
- entertainment
Tutti i look di Margot Robbie in stile Cime tempestose
Nelle sale dal 12 febbraio, la versione gothic pop del grande classico di Emily Bronte fa discutere
- fashion
Il ritorno delle It-bag anni 2000: quali sono i modelli da comprare ora
Dagli archivi delle maison alle passerelle 2026: le borse Y2K che hanno definito un’epoca stanno tornando
- lifestyle
Perché Gibellina è diventata la prima Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea
Con il progetto Portami il futuro, la città del Belice apre il suo anno speciale nel 2026
- living
San Valentino da vivere: cinque esperienze gourmet da regalare
Cene romantiche, fughe golose, momenti sensoriali e perfino feste con i nostri animali domestici: il regalo più prezioso è il tempo passato insieme e i ricordi che restano
- fashion
Tendenze eyewear a Mido 2026, se il mondo si guarda attraverso una lente
Vintage o supertecnologici, oversize o minimal, trasparenti o colorati. E poi i modelli sportivi sulla scia dell’attenzione per gli sport invernali in scena a Milano Cortina. Ecco tutti i trend dell'occhialeria per la prossima Primavera-Estate
- entertainment
Ilia Malinin alle Olimpiadi invernali 2026, il salto proibito che ha fatto la storia
A Milano Cortina 2026 Ilia Malinin trascina gli Stati Uniti all’oro nel team event con una performance ad altissimo contenuto tecnico
- lifestyle
Cineturismo 2026: le destinazioni da vedere dal vivo dopo averle amate davanti allo schermo
Nel 2026 si viaggia per entrare nelle storie: Thailandia, Seoul, Parigi e Italia sono il “set diffuso” che guida il boom del set-jetting
- fashion
5 scarpe must-have per passare dall'inverno alla primavera 2026
Dalle slingback alle sneaker ibride: guida alle scarpe chiave della primavera in arrivo, tra modelli versatili, silhouette intelligenti e tendenze per i look del cambio stagione
- beauty
Il rossetto per San Valentino, a ognuna il suo colore
Intensi e sexy nei toni del rosso o più discreti in rosa candy. I nuovi lipstick dalla texture matte, più idratante oppure glossy
- Entertainment
Il Benito Bowl, Bad Bunny ha trasformato il Super Bowl in un manifesto di stile
Il cantante realizza un Halftime Show monumentale lanciando un messaggio potente e portando sul palco a sorpresa anche Lady Gaga e Ricky Martin
- entertainment
I film e la neve, quando la montagna diventa simbolo di sfida estrema
Con le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 torna la voglia di atmosfere che evochino la conquista, il limite fisico e morale