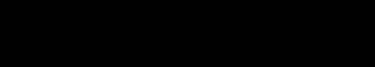David Bowie, perché a 10 anni dalla morte detta ancora tendenza
A dieci anni dalla scomparsa di David Bowie, un ritratto profondo e verificato dell’artista che ha cambiato per sempre musica, moda e identità. Dal fulmine di Aladdin Sane a Ziggy Stardust, dai designer che lo hanno vestito alle mostre che ne custodiscono l’eredità, ecco perché il mondo senza Bowie è ancora più vuotoDi Giuditta Avellina
Il 10 gennaio 2016 David Bowie se n’è andato in silenzio, due giorni dopo aver pubblicato Blackstar. Non un disco di commiato, ma un’opera concepita come gesto finale, in cui l’addio è già parte della regia. A risuonare, però, in quelle ore non è stata solo la sua ultima musica, ma un verso molto più lontano nel tempo: We can be heroes, just for one day, inciso nel 1977, e improvvisamente caricato di un nuovo significato (oggi tornata in vetta alle classifiche grazie al finale di Stranger Things).
Ciò che conta, ciò che resta sospeso tra la vita e la dipartita, non è la cronaca - la malattia tenuta privata, l’uscita dell’album a ridosso della fine - ma l’effetto collettivo: all’improvviso, il mondo pop è apparso più vuoto. Non perché fosse scomparsa una delle star più influenti di sempre, ma perché veniva meno un linguaggio, uno stile, un modo di abitare l’identità e il cambiamento. Non abbiamo perso soltanto la possibilità di nuovi brani iconici, né solo un genio multiforme. Abbiamo perso uno degli autori più radicali di immaginari del Novecento e oltre. Qualcuno che non si limitava a far sognare, ma che ha insegnato come diventare, anche solo per un giorno, ciò che si desiderava essere, un inaspettato ed eroe del quotidiano.

Perché David Bowie è stato così importante per la moda
David Bowie ha spostato l’asse della relazione tra musica e moda: non si trattava solo di “look di scena”, ma di una vera e propria costruzione narrativa. Trucco, capelli, tagli, silhouette diventavano strumenti al pari di un arrangiamento. La sottile linea tra estetica e drammaturgia che ha permesso a Bowie di permanere oltre ogni spazio e tempo. Nei musei, nelle strade, nella musica, in passerella, negli archivi dei designer, più che come una tendenza, come un vero e proprio assioma.
Basti pensare, ad esempio, a un'immagine potente e cristallizzata nella cultura pop come può essere stata la cover dell'album Aladdin Sane. Il fulmine impresso sul volto di David Bowie, quella linea che taglia il volto, ha trasformato il makeup in simbolo, al punto da diventare replicabile, citabile, campionabile come un riff. Il fulmine fu realizzato dal makeup artist Pierre La Roche e la costruzione dell’immagine, nella sua versione definitiva, coinvolse anche l’airbrush artist Philip Castle.

I capelli sono l’altra metà della costruzione bowiana: il rosso acceso e innaturale di Ziggy Stardust, tagliato in modo netto e quasi alieno, rompeva con ogni codice rock precedente, il biondo platino e levigato del Thin White Duke segnava invece una fase di controllo, freddezza e distacco emotivo.
Le lunghezze più morbide e naturali degli anni Ottanta accompagnavano una stagione di maggiore accessibilità pop. In ogni fase, la capigliatura non era un dettaglio estetico ma un segnale narrativo: Bowie usava i capelli per dichiarare chi stava diventando, prima ancora di farlo con la musica.

Ziggy Stardust, la moda, gli stili dei multiformi di David Bowie
Ziggy non è solo un personaggio: è uno spartiacque estetico. È il punto in cui gender, teatralità e pop diventano un patto pubblico. Qui entrano in gioco due nomi fondamentali, spesso ridotti a nota a margine e invece centrali. Il primo è Kansai Yamamoto, che per Bowie costruì una serie di outfit destinati a riscrivere l’idea stessa di costume rock: volumi, segni, riferimenti al Giappone, una teatralità che non chiedeva permesso. La collaborazione - soprattutto nei primi anni ’70 - è oggi letta come un passaggio decisivo per la nascita di un immaginario gender-fluid.

Il secondo nome chiave è quello di Freddie Burretti, designer fondamentale per l’estetica di Ziggy Stardust e per il Bowie di Life on Mars?. Burretti contribuì a definire un tailoring pop essenziale ma affilato, pensato per funzionare davanti alla macchina da presa e sul palco. Abiti che oggi appaiono “semplici” solo perché costruiti con precisione assoluta.

Dopo l’esplosione glam, Bowie dimostra di saper fare l’opposto: sottrazione, controllo, rigore. Il Thin White Duke è silhouette e postura: camicia, gilet, pantaloni, una disciplina visiva che sembra classica ma risulta straniante. È una lezione fondamentale per la moda maschile contemporanea: la sensualità non sta solo nell’eccesso, ma anche nel taglio e nel non detto.
Alexander McQueen e Thierry Mugler, l’incontro tra visionari
Tra le collaborazioni più emblematiche di David Bowie c’è quella con Alexander McQueen: la Union Jack frock coat del 1996, resa iconica nell’era Earthling, tiene insieme heritage e sabotaggio, romanticismo e ferita. Bowie scelse McQueen quando non era ancora un nome scontato, e non a caso ai VH1 Fashion Awards di quello stesso anno performò con quel linguaggio addosso, fondendo musica e moda in un’unica dichiarazione.
Accanto a questo dialogo, Bowie attraversò anche la moda più teatrale e scultorea di Thierry Mugler, che concepiva il corpo come architettura e creatura visionaria: un immaginario affine al suo, destinato a sedimentare nell’iconografia pop e a influenzare generazioni successive.

Come la musica di David Bowie ha cambiato lo stile
La forza di David Bowie è nell’aver fuso musica, immagine e racconto. Ogni album di svolta è stato anche una svolta estetica. Ziggy Stardust impone il glam come linguaggio sonoro e visivo, Aladdin Sane trasforma il successo globale in un’icona pop immediata. Con Young Americans Bowie abbraccia soul e funk, adottando uno stile più elegante e corporeo.
La trilogia berlinese (Low, “Heroes”, Lodger) porta a una radicale sottrazione: elettronica, introspezione, copertine austere. Negli anni Novanta, tra Outside ed Earthling, immagine e suono tornano a frantumarsi, fino a Blackstar, sintesi finale di jazz, avanguardia e simbolismo. La moda lo ha seguito perché ogni disco apriva un nuovo mondo da abitare, non solo da indossare.
David Bowie come patrimonio culturale
La consacrazione museale di David Bowie non è mai stata puramente celebrativa, ma strutturale. Nel 2013 il Victoria and Albert Museum ha inaugurato David Bowie Is, una delle mostre più visitate della sua storia, capace di ridefinire il racconto museale di un artista pop attraverso costumi, video, suoni e archivi personali. Oggi quel percorso trova una sede permanente: nel 2025 apre al pubblico il David Bowie Centre all’interno del V&A East Storehouse di Londra, spazio dedicato alla consultazione dell’archivio Bowie e alle esposizioni in rotazione, pensato come luogo di studio e non di nostalgia.

Accanto alla dimensione istituzionale, resta quella simbolica e privata. Bowie riceve la stella sulla Hollywood Walk of Fame nel 1997, consacrazione definitiva di una carriera globale. Sul piano personale, la relazione con Iman - conosciuta nel 1990 e sposata nel 1992 - rappresenta una delle storie d’amore più solide e longeve dello show business, durata fino alla sua morte nel 2016.
Un equilibrio raro, che completa il ritratto di un artista capace di essere icona pubblica e uomo profondamente privato. È la prova più chiara che, a dieci anni dalla scomparsa, Bowie non appartiene alla commemorazione, ma a un presente che continua a studiarlo, interrogarlo, usarlo come riferimento. È questo il suo peso specifico: aver reso naturale l’avanguardia e, più ancora il crederci, il "non è finita finché non è finita". In fondo, l’eredità soggiace tutta lì: we can be heroes, just for one day.

Contenuti consigliati
- living
Dolce dormire: layering, morbidezze e quei cinque minuti in più
Manuale di sopravvivenza per chi ama dormire: il design prende la parola, tra letti che diventano rifugio e biancheria più avvolgente che mai
- living
One dish: cos’è la nuova tendenza del piatto unico
Dal bento giapponese all’entrecôte francese, il nuovo trend food è riscoprire il valore di una proposta sola, ma memorabile
- fashion
Milano Fashion Week FW26/27: il calendario delle sfilate tra debutti, grandi ritorni e Olimpiadi
Dal 24 febbraio al 2 marzo Milano torna capitale della moda con la Women’s Collection FW 2026/27 tra debutti creativi, nuovi brand
- ENTERTAINMENT
BAFTA 2026: il ritorno di Kate Middleton e tutti i look più belli della serata
La Principessa ha affiancato William sul red carpet degli Oscar britannici conquistando tutti con un look semplice e sofisticato. Tra le star meglio vestite Emma Stone e Monica Bellucci
- beauty
Bellezza ad alta quota: 4 trattamenti corpo da provare
Bagni di vapore, erbe aromatiche e neve: l’essenza della montagna si trasforma in rituali di benessere che rigenerano mente e corpo
- lifestyle
Grandi hotel e cavalli: binomio perfetto per soggiorni da sogno
Trascorrere del tempo in questi luoghi significa collezionare esperienze e ricordi indimenticabili
- beauty
Blurred lips, la tendenza labbra che ha conquistato anche Hollywood
Emma Stone, Kaia Gerber e Margaret Qualley sono solo alcune delle star pazze per il trucco che aumenta il volume della bocca in modo naturale (e senza gloss)
- fashion
5 look Anni ‘90 di Carolyn Bessette da copiare oggi
Dalla camicia bianca alla pencil skirt al cappotto sartoriale: 5 look timeless della moglie di John Fitzgerald Kennedy Jr.
- fashion
Nuove sfide della moda: cos'è il Millennial Optimism e perché potrebbe ridefinire il futuro della moda
Dalla fine dell’era dei grandi maestri a un’ondata di nuove nomine: con i numerosi cambi ai vertici delle maison, il sistema moda vive il più ampio passaggio generazionale degli ultimi anni
- living
Mangiare al museo: cinque indirizzi dove l’arte continua a tavola
Tra quadri, architetture iconiche e piatti d’autore, ecco i musei che oggi si visitano anche con il palato. Perché oggi l’arte non si guarda soltanto, si assapora con gusto
- X-STYLE PER NAJ OLEARI
Petalicious di Naj Oleari, Sanremo si tinge di rosa tra make up ed experience beauty
X-STYLE PER NAJ OLEARI
- fashion
Cappotto in primavera: i modelli e i colori per accogliere la bella stagione
Lungo o corto. Colorato, decorato o nelle nuances passe-partout, dal bianco al nero
- fashion
Tutte le sfumature dello scollo a barchetta e come abbinarlo
Dona ai capi un’allure elegante e slancia la figura. Lo scollo a barchetta torna come must-have dal sapore retrò: dagli abiti ai maglioni. Le linee amate da Audrey Hepburn conquistano le collezioni Primavera-Estate 2026.
- fashion
London Fashion Week FW2627: l’omaggio a Paul Costelloe, il designer che vestì Lady Diana
La sfilata che ha aperto simbolicamente la settimana della moda londinese si trasforma in un ideale passaggio dalla vecchia alla nuova guardia del fashion system
- entertainment
Eileen Gu vs Jutta Leerdam, la sfida olimpica tra sport, moda e follower
Medaglie, milioni di follower e brand globali: a Milano Cortina 2026 la sfida tra la sciatrice e la pattinatrice racconta due visioni opposte ma complementari dell’atleta contemporanea, tra lusso istituzionale e cultura pop digitale
- living
L’Italia in una tazzina: i caffè più amati e identitari
Dal Bicerin torinese al caffè del professore napoletano, passando per Trieste e Palermo
- Entertainment
Jacob Elordi: il villain romantico che riscrive le regole
Dal rapporto con la madre ai look che dialogano con il guardaroba femminile. L’Heathcliff di Emerald Fennell è il (non) eroe romantico del 2026
- entertainment
Cindy Crawford compie 60 anni. Perché la top model rimane un’icona degli Anni '90
Nei Nineties è tra le regine delle passerelle, rappresentante dello stile effortless nella vita quotidiana e pronta a sfoggiare abiti da red carpet. Cindy Crawford spegne 60 candeline, confermandosi simbolo di eleganza e stile, spesso accanto alla figlia Kaia. I suoi look, di ieri e di oggi, lo dimostrano
- entertainment
È lo sport il nuovo red carpet?
Non più solo competizione, ma linguaggio visivo, piattaforma culturale e nuova passerella globale
- Fashion
Sposa in tailleur: la tendenza bridal fa ritorno per la stagione dei matrimoni
Il tailleur bianco si conferma – per le spose di ieri e di oggi - il manifesto bridal più potente di sempre
- beauty
Come proteggersi dal sole, anche in montagna
I raggi sono onnipresenti, in città, al mare e anche sulla neve. Per preservare la salute e la bellezza della pelle si può ricorrere a formule intelligenti, leggere e facili da applicare (persino sugli sci)
- entertainment
Carnevale nei film: 5 titoli per celebrare la maschera e il doppio
Il cinema ha saputo spesso raccontare che l'identità non è un dato fisso, ma una scelta, una performance
- fashion
Marrone “is the new black”. La tinta terrosa che piace a star e principesse
È il colore che ha dominato la stagione fredda e che si conferma il preferito dalle dive
- living
Carnevale, ma d’autore: i dolci imperdibili riletti dagli chef
Chiacchiere, castagnole, frittelle e ravioli dolci tra memoria e innovazione: quando la tradizione incontra la firma dei grandi maestri della pasticceria italiana