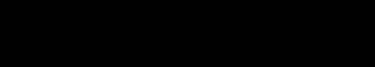Le macchine fotografiche con il rullino: il fascino dell’imperfetto
Dalle fotocamere a telemetro al ritorno delle usa e getta, fino alle istantanee e ai grandi formati: la fotografia analogica riscopre il suo fascino vintage, dove il design racconta la tecnologia e l’imperfezione diventa stile
Le macchine fotografiche analogiche non inseguono la perfezione: la smascherano. In un tempo che ritocca tutto, il rullino resta un atto di onestà. Non è un ritorno, ma un cambio di sguardo: oggi la macchina fotografica analogica vive tra le mani di chi preferisce la luce alla postproduzione, l’attesa all’anteprima. Come alcune radio dal gusto retrò, anche le nuove fotocamere a pellicola, con leve, ghiere e corpi d’acciaio, conservano la forma delle loro antenate come se il design fosse memoria. Scattare su pellicola è un gesto lento e consapevole, come scrivere con una stilografica: ogni errore è irripetibile, e quindi perfetto.

Ma attenzione, perché le pellicole non sono tutte uguali. Il numero che le definisce — 35 mm, 120 mm o 110 mm — indica la larghezza della pellicola e quindi la dimensione del fotogramma. Il 35 mm è il formato più comune: nasce nel cinema e, grazie a Leica, diventa lo standard della fotografia moderna per equilibrio tra qualità e portabilità. Il 120 mm è il regno del medio formato: pellicola larga circa sei centimetri, negativi fino a 6 × 9 cm e una profondità d’immagine impareggiabile, a costo di fotocamere più ingombranti. Il piccolo 110 mm, lanciato da Kodak negli anni Settanta, era pensato per le compatte tascabili: pratico, economico, ma con una resa più morbida.
Meccaniche d’élite
Il 35 mm è il formato più utilizzato in assoluto anche dalle macchine fotografiche con una meccanica d’elite: tra queste, le fotocamere a telemetro ottico per la messa a fuoco manuale. A differenza delle reflex, il fotografo non guarda attraverso l’obiettivo, ma attraverso un mirino separato che include una piccola area, detta patch, dove vengono mostrate due immagini del soggetto: una fissa e una mobile. La messa a fuoco si ottiene allineandole perfettamente ruotando l’anello sull’obiettivo. Queste macchine sono apprezzate per la loro compattezza, silenziosità e per un mirino luminoso che non si oscura mai al momento dello scatto. Sono storicamente associate a marchi come Leica e alla street photography, dove la discrezione e la velocità contano più della potenza di fuoco.

Il brand tedesco ha continuato a produrre negli anni corpi interamente meccanici come la M-A (Typ 127), priva persino di esposimetro, e la più recente M6. Questi modelli non sono solo strumenti, ma dichiarazioni d’intenti: nessuna elettronica, nessuna obsolescenza, solo ottone, ingranaggi e fiducia nella luce. Il mercato, seppur di nicchia, è florido: una Leica analogica nuova parte da circa 5.000 euro e può superare gli 8.000, ma mantiene nel tempo un valore che molti smartphone perdono dopo sei mesi.

Nuova analogia
Se il lusso analogico è un club privato, la vera notizia è che i piaceri dell’arte analogica si possono sperimentare anche attraverso apparecchiature più a buon mercato. Un esempio è la Pentax 17, una fotocamera compatta a pellicola che usa il formato half frame, cioè mezzo fotogramma per ogni scatto. Tradotto: 72 immagini su un rullino da 36 pose. È un’idea semplice per ridurre il costo a scatto e avvicinare le nuove generazioni a un’esperienza tangibile. La 17 non ha display né autofocus predittivo, ma una leva di carica manuale e un’esposizione a zone. Costa meno di una mirrorless base, ma restituisce qualcosa che nessuna app può simulare: l’imprevedibilità.

Accanto a Pentax si muove un fronte accessibile e diretto, fatto di compatte riutilizzabili come la Kodak M35, la Yashica MF-1 e le Agfa Argentica. Sono macchine che riportano la fotografia all’essenziale: un rullino da 35 mm, un flash, e una sola regola — inquadrare e scattare. Queste fotocamere utilizzano un otturatore meccanico fisso, cioè una velocità di scatto impostata in fabbrica (in genere 1/100 o 1/125 di secondo) che non può essere modificata dall’utente. L’esposizione resta sempre la stessa, adatta alla luce diurna, e per interni o notturni serve il flash o una pellicola più sensibile. È la semplicità assoluta: nessun display, nessuna opzione, solo il rumore secco dell’otturatore e la curiosità di vedere cosa è venuto fuori.

Ad utilizzare i formati più particolari come il 6,4,5, 6x6, o il 6x9 è Lomography, che nel tempo ha recuperato i brevetti di diversi modelli storici europei del Novecento, reinterpretandoli in chiave contemporanea. Le sue fotocamere, come la LomoApparat (35 mm), la Diana F+ (120 mm) o la Lomomatic 110, sono veri e propri omaggi alla diversità tecnica della fotografia analogica.
Con i loro obiettivi in plastica, i corpi leggeri e la totale assenza di automatismi, le fotocamere Lomography rifiutano la perfezione per esaltare il caso. In dotazione c’è quasi sempre del nastro nero per coprire le fughe di luce nel corpo macchina. Non promettono nitidezza, ma libertà. Le immagini che producono — spesso sovraesposte, distorte o sfocate — sono un piccolo manifesto poetico dell’imperfezione.

La stagione dell’usa e getta
Tra i simboli più democratici dell’analogico c’è la fotocamera usa e getta. Nata negli anni Ottanta per semplificare lo scatto amatoriale, è tornata oggi come accessorio vintage di culto. Kodak, Fujifilm e AgfaPhoto continuano a produrle quasi identiche alle originali: corpo in plastica, pellicola da 35 mm preinserita e flash integrato. Una volta finito il rullino, si consegna tutto al laboratorio, che recupera la pellicola e ricicla la scocca.
La filosofia resta invariata: semplicità estrema, un solo pulsante, una sola possibilità. L’otturatore è meccanico fisso, la messa a fuoco è fissa e il risultato quasi sempre imprevedibile. Ma è proprio questa incertezza a renderle affascinanti. Alcuni brand hanno persino reintrodotto versioni subacquee, impermeabili fino a 10 metri, per le vacanze e i reportage estivi. Il loro successo è anche sociologico: nella fotografia usa e getta non c’è editing, non c’è anteprima, non c’è controllo. È l’immagine che comanda, non chi la scatta.

L’effimero che resta
Se la pellicola tradizionale è lentezza, la fotografia istantanea è la sua sorella estroversa: in questo caso si scatta per condividere subito. Un’immagine che nasce già stampata, con il profumo della chimica e il calore della carta. La rinascita ha due protagonisti storici: Polaroid e Fujifilm. La prima ha ritrovato sé stessa con prodotti che partono da 90 euro fino a toccare i 600 della Polaroid I-2. Quest’ultima è tra le istantanee più avanzate mai costruite grazie ai controlli manuali e all’obiettivo Ricoh. Fujifilm, invece, domina con la serie Instax nei diversi formati — Mini, Square e Wide — e si adatta a diverse sensibilità fino a toccare ISO 800 per la fotografia notturna. Ma ci sono anche quelle diventate ibride cioè digitali e analogiche.
Accanto a questi due colossi si è aperta una terza via, pensata per chi vive la fotografia istantanea come estensione del proprio smartphone. Canon, con la linea Zoemini, unisce fotocamera digitale e stampante termica. Kodak, dal canto suo, ha rilanciato la filosofia dello scatto tangibile con i modelli Mini Shot, anch’essi basati su stampa a sublimazione per colori più vividi e una definizione sorprendente.

Oltre il tempo
C’è poi un’ultima categoria di appassionati: quelli che rifiutano l’obsolescenza. In garage e laboratori artigianali, il grande formato torna protagonista. La Smartflex 4x5 di Reflx Lab è una fotocamera a pellicola di nuova generazione che può ospitare sia sensori digitali che pellicole, e si comanda anche via Bluetooth. È il perfetto esempio di come l’analogico possa dialogare con il digitale senza perdere identità.
Anche l’ibrido tecnologico avanza. L’azienda svizzera I’m Back GmbH ha sviluppato un “rullino digitale” con sensore Micro Quattro Terzi: si inserisce al posto della pellicola in vecchie reflex 35 mm e le trasforma in camere digitali. È un modo per far rivivere modelli come la Canon AE-1, la Nikon FM2 o la Leica R6, senza tradire la loro ergonomia originale.

Queste invenzioni non rispondono solo a un desiderio di design, ma a un bisogno culturale: rallentare. La pellicola, oggi, è il contrario della certezza del risultato. Costa, richiede tempo, chiede attenzione. Ma proprio in questo è la sua forza. In un mondo dove la memoria è fatta di file che si cancellano e di immagini lisce come vetro, la fotografia analogica conserva la ruvidità del reale. È il ritorno al gesto, al limite, all’attesa. La pellicola non è mai morta. È solo diventata ciò che ogni oggetto perfetto sogna di essere: imperfetta, ma eterna.
Leggi anche:
Dove il brunch diventa esperienza: gli indirizzi più iconici in Italia
Contenuti consigliati
- fashion
Milano Fashion Week FW26-27: la prima volta del duo Silvana Armani-Leo Dell'Orco da Emporio Armani è un dialogo tra maschile femminile
Dopo il debutto, a gennaio, del compagno di Re Giorgio nella collezione Uomo e quello della nipote Silvana nell’Haute Couture parigina
- fashion
Milano Fashion Week FW 26-27: la continuità di Prada
Una collezione femminile che è la prosecuzione di quella maschile presentata lo scorso gennaio, tra sprazzi di colore, contrasti e i segni distintivi della maison
- lifestyle
Troubetzkoy in mostra alla GAM, il ritrattista della Belle Époque che scolpiva la vita
Dal 27 febbraio al 28 giugno 2026 la GAM di Milano dedica una grande retrospettiva a Paul Troubetzkoy
- Fashion
Milano Fashion Week FW26-27: da Jil Sander a Missoni fino ad Etro, cosa è successo nel secondo giorno di passerelle
Il prossimo Autunno/Inverno prende forma tra le linee rigorose di Jil Sander, le righe iconiche di Missoni e i dettagli originali di Etro. In passerella anche il romanticismo di Luisa Beccaria, il ritorno alla lentezza di Marras e le ibridazioni di MM6 Maison Margiela
- fashion
Giacca in suede: i modelli su cui puntare per la Primavera 2026
Dal blazer oversize al trench in camoscio, la giacca in suede è il capo che risolve qualsiasi tipo di dubbio sugli outfit della Primavera
- fashion
Milano Fashion Week FW26-27, Fendi ricomincia da Maria Grazia Chiuri
Il debutto del nuovo direttore creativo con la collezione Autunno/Inverno 2026-2027 segna l’inizio del nuovo corso della maison
- beauty
Unghie 2026, tre tendenze (anche vintage) da provare subito
Per una manicure diversa dal solito, originale e ricercata, basta ispirarsi alle mani delle star
- living
Una rondine non fa primavera. Ma un vaso colorato, sì
A chi vorrebbe il sole già dentro casa, il design risponde con palette al gusto sorbetto, riflessi e forme iconiche
- fashion
Milano Fashion Week FW26-27, Diesel e i debutti in calendario
La settimana della moda italiana si apre con il cocktail del Fashion Hub e la sfilata di Diesel, ma anche sotto il segno di nuovi nomi in calendario
- beauty
Centella asiatica, ecco perché la chiamano "erba di tigre"
Lenitiva e antirossore, è l’ingrediente cosmetico star dei trattamenti per la pelle sensibile e irritata
- fashion
Ballerine, il grande ritorno della scarpa flat tra passerelle e celebrity
Dalle collezioni di Dior, Valentino e Chanel alle scelte di stile di Katie Holmes o Inès de la Fressange
- living
Dolce dormire: layering, morbidezze e quei cinque minuti in più
Manuale di sopravvivenza per chi ama dormire: il design prende la parola, tra letti che diventano rifugio e biancheria più avvolgente che mai
- living
One dish: cos’è la nuova tendenza del piatto unico
Dal bento giapponese all’entrecôte francese, il nuovo trend food è riscoprire il valore di una proposta sola, ma memorabile
- fashion
Milano Fashion Week FW26/27: il calendario delle sfilate tra debutti, grandi ritorni e Olimpiadi
Dal 24 febbraio al 2 marzo Milano torna capitale della moda con la Women’s Collection FW 2026/27 tra debutti creativi, nuovi brand
- ENTERTAINMENT
BAFTA 2026: il ritorno di Kate Middleton e tutti i look più belli della serata
La Principessa ha affiancato William sul red carpet degli Oscar britannici conquistando tutti con un look semplice e sofisticato. Tra le star meglio vestite Emma Stone e Monica Bellucci
- beauty
Bellezza ad alta quota: 4 trattamenti corpo da provare
Bagni di vapore, erbe aromatiche e neve: l’essenza della montagna si trasforma in rituali di benessere che rigenerano mente e corpo
- lifestyle
Grandi hotel e cavalli: binomio perfetto per soggiorni da sogno
Trascorrere del tempo in questi luoghi significa collezionare esperienze e ricordi indimenticabili
- beauty
Blurred lips, la tendenza labbra che ha conquistato anche Hollywood
Emma Stone, Kaia Gerber e Margaret Qualley sono solo alcune delle star pazze per il trucco che aumenta il volume della bocca in modo naturale (e senza gloss)
- fashion
5 look Anni ‘90 di Carolyn Bessette da copiare oggi
Dalla camicia bianca alla pencil skirt al cappotto sartoriale: 5 look timeless della moglie di John Fitzgerald Kennedy Jr.
- fashion
Nuove sfide della moda: cos'è il Millennial Optimism e perché potrebbe ridefinire il futuro della moda
Dalla fine dell’era dei grandi maestri a un’ondata di nuove nomine: con i numerosi cambi ai vertici delle maison, il sistema moda vive il più ampio passaggio generazionale degli ultimi anni
- living
Mangiare al museo: cinque indirizzi dove l’arte continua a tavola
Tra quadri, architetture iconiche e piatti d’autore, ecco i musei che oggi si visitano anche con il palato. Perché oggi l’arte non si guarda soltanto, si assapora con gusto
- X-STYLE PER NAJ OLEARI
Petalicious di Naj Oleari, Sanremo si tinge di rosa tra make up ed experience beauty
X-STYLE PER NAJ OLEARI
- fashion
Cappotto in primavera: i modelli e i colori per accogliere la bella stagione
Lungo o corto. Colorato, decorato o nelle nuances passe-partout, dal bianco al nero
- fashion
Tutte le sfumature dello scollo a barchetta e come abbinarlo
Dona ai capi un’allure elegante e slancia la figura. Lo scollo a barchetta torna come must-have dal sapore retrò: dagli abiti ai maglioni. Le linee amate da Audrey Hepburn conquistano le collezioni Primavera-Estate 2026.