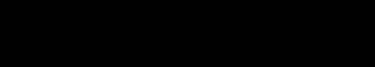La musica italiana sulle passerelle e nel cinema: quando lo stile incontra la memoria
Dalla Spring Summer 2026 di Dolce & Gabbana con Patty Pravo agli omaggi di Virzì, Özpetek e Sorrentino: la musica italiana non è mai semplice sottofondo, ma architettura narrativa che riveste di emozione la moda e il cinema
Quando la moda canta
Quando la moda italiana incontra la sua musica, non nasce un semplice sottofondo: prende vita un racconto identitario. È accaduto alla Milano Fashion Week, dove la Spring Summer 2026 di Dolce & Gabbana ha trasformato la passerella in un palcoscenico emotivo grazie a tre brani di Patty Pravo – Notti bianche, Pensiero stupendo e Qui e Là.
La voce della cantante veneziana ha scandito il ritmo degli abiti, guidato i giochi di luce e cucito insieme le falcate delle modelle, come una drammaturgia sonora che non si limita ad accompagnare ma a raccontare. Un notturno sensuale con Notti bianche (versione italiana di It’s a Heartache), una scossa trasgressiva con Pensiero stupendo, un’eco sixties leggera con Qui e Là: tre atmosfere, tre stati d’animo, un’unica narrazione.
Così la memoria musicale italiana è diventata tessuto invisibile della collezione, dimostrando ancora una volta che le passerelle, come il cinema, non si limitano a mostrare: mettono in scena e lo fanno con un sottofondo profondamente, intensamente italiano.

Le passerelle come palcoscenici sonori
Le maison italiane hanno spesso trasformato la passerella in autentici palcoscenici musicali, facendo della colonna sonora un dispositivo narrativo. Dolce & Gabbana, fin dagli anni Novanta, hanno scelto come cifra stilistica Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni, che — secondo il loro stesso archivio — fu la prima musica a inaugurare le loro sfilate nel 1984. L’opera, intrisa di radici siciliane e dramma verista, è riemersa in momenti-chiave: dall’evento di Alta Moda a Siracusa nel 2022, dove la collezione fu presentata nel Teatro Greco con la partitura come leitmotiv, fino alla collezione uomo AI 2025-26, accompagnata da nuovi arrangiamenti tratti dalla stessa partitura.
Gucci, con il debutto di Sabato De Sarno nella Spring Summer 2024, ha invece affidato la regia sonora a Mark Ronson, che ha combinato atmosfere orchestrali e riferimenti pop italiani, culminando in un remix di Ancora, ancora, ancora di Mina, divenuto virale su TikTok e Instagram.
Versace, in diverse stagioni, ha arricchito le playlist ufficiali con brani di Mina e Lucio Battisti, evocando l’immaginario solare e spensierato dell’Italia anni ’60. Valentino, fedele al suo registro intimista, ha spesso scelto brani di Paolo Conte, le cui melodie sospese trasformano il défilé in un concerto poetico.
Moschino, infine, ha tradotto in chiave pop-art partiture cinematografiche di Nino Rota, piegandole a un’estetica ironica e destabilizzante. Non si tratta mai di semplici sottofondi musicali: queste selezioni agiscono come architetture narrative che dialogano con tessuti, luci e volumi, trasformando la sfilata in un’esperienza immersiva e totale.

Cinema e canzone: un dialogo di emozioni
Nel cinema italiano, le canzoni non accompagnano: mettono in scena. In La finestra di fronte (2003) di Ferzan Özpetek, Giorgia firma e interpreta Gocce di memoria (musica di Andrea Guerra), vincendo il Nastro d’Argento e trasformando un dramma intimo in racconto collettivo. In La prima cosa bella (2010), Paolo Virzì costruisce il senso stesso del film sull’omonimo classico di Nicola Di Bari, reinterpretato da Malika Ayane con una delicatezza che amplifica il gioco di nostalgia luminosa al centro della storia.
Con Paolo Sorrentino, l’omaggio alla musica italiana è diventato marchio stilistico. In Parthenope (2024) la colonna sonora ruota attorno a Era già tutto previsto di Riccardo Cocciante (1975), canzone-mantra che attraversa i personaggi e affiancata da Che cosa c’è di Gino Paoli, in un intreccio che rinnova l’eredità dei cantautori anni ’60.
In Il Divo (2008) Sorrentino inserisce La prima cosa bella dei Ricchi e Poveri, dolceamaro contrappunto al ritratto di Andreotti, in La grande bellezza (2013) fa esplodere l’immaginario pop con A far l’amore comincia tu di Raffaella Carrà nel remix di Bob Sinclar, simbolo di un’euforia che diventa decadenza. Ma già negli anni Sessanta e Settanta la canzone d’autore italiana aveva iniziato a dialogare con il cinema: Luigi Tenco, ad esempio, portò la sua voce e le sue canzoni sullo schermo ne La cuccagna di Luciano Salce, restituendo al pubblico l’immagine di una gioventù inquieta e disillusa.

Gino Paoli vide uno dei suoi brani più celebri, Il cielo in una stanza, diventare colonna emotiva di Io la conoscevo bene di Antonio Pietrangeli, dove accompagnava la fragilità luminosa del personaggio di Stefania Sandrelli. E negli stessi anni Lucio Dalla intrecciava la propria ricerca musicale con le immagini di Pupi Avati, firmando partiture originali per film come La casa dalle finestre che ridono, capaci di aggiungere inquietudine e poesia al racconto.
Tre esempi diversi, ma uniti dallo stesso effetto: fissare nel cinema atmosfere e sentimenti che la musica, da sola, non avrebbe potuto trattenere, e che grazie alle immagini sono diventati memoria collettiva.
Moda, cinema, musica: il triangolo identitario, il lusso del ricordo

Tre linguaggi diversi, un’unica funzione: raccontare chi siamo. La moda veste i corpi, la musica amplifica i sentimenti, il cinema li trasforma in storie. Insieme, creano un triangolo identitario che si alimenta di ricordi e immaginari condivisi.
Quando Patty Pravo diventa colonna sonora di Dolce & Gabbana, quando Giorgia amplifica il racconto di Özpetek, quando una passerella riecheggia di Nino Rota, il gesto è sempre lo stesso: custodire un patrimonio e renderlo vivo. In un presente che consuma con velocità, riportare la musica italiana sulle passerelle o al cinema significa scegliere la profondità del ricordo.
Il vero lusso non è indossare un abito unico, ma condividere un patrimonio emotivo. Patty Pravo, Giorgia, Dalla, Cocciante, Paoli o Rota non sono soltanto note: sono specchi di un’identità. E quando risuonano tra i flash di una sfilata o nel buio di una sala, la memoria si rinnova. Diventando emozione viva, ancora capace di vestire lo stile italiano.
Leggi anche.
Bad Bunny al Super Bowl: quando il reggaeton diventa touchdown di stile
Lady Gaga e Michael Polansky: l’amore raccontato attraverso lo stile
Contenuti consigliati
- fashion
Milano Fashion Week FW26-27, Diesel e i debutti in calendario
La settimana della moda italiana si apre con il cocktail del Fashion Hub e la sfilata di Diesel, ma anche sotto il segno di nuovi nomi in calendario
- beauty
Centella asiatica, ecco perché la chiamano "erba di tigre"
Lenitiva e antirossore, è l’ingrediente cosmetico star dei trattamenti per la pelle sensibile e irritata
- fashion
Ballerine, il grande ritorno della scarpa flat tra passerelle e celebrity
Dalle collezioni di Dior, Valentino e Chanel alle scelte di stile di Katie Holmes o Inès de la Fressange
- living
Dolce dormire: layering, morbidezze e quei cinque minuti in più
Manuale di sopravvivenza per chi ama dormire: il design prende la parola, tra letti che diventano rifugio e biancheria più avvolgente che mai
- living
One dish: cos’è la nuova tendenza del piatto unico
Dal bento giapponese all’entrecôte francese, il nuovo trend food è riscoprire il valore di una proposta sola, ma memorabile
- fashion
Milano Fashion Week FW26/27: il calendario delle sfilate tra debutti, grandi ritorni e Olimpiadi
Dal 24 febbraio al 2 marzo Milano torna capitale della moda con la Women’s Collection FW 2026/27 tra debutti creativi, nuovi brand
- ENTERTAINMENT
BAFTA 2026: il ritorno di Kate Middleton e tutti i look più belli della serata
La Principessa ha affiancato William sul red carpet degli Oscar britannici conquistando tutti con un look semplice e sofisticato. Tra le star meglio vestite Emma Stone e Monica Bellucci
- beauty
Bellezza ad alta quota: 4 trattamenti corpo da provare
Bagni di vapore, erbe aromatiche e neve: l’essenza della montagna si trasforma in rituali di benessere che rigenerano mente e corpo
- lifestyle
Grandi hotel e cavalli: binomio perfetto per soggiorni da sogno
Trascorrere del tempo in questi luoghi significa collezionare esperienze e ricordi indimenticabili
- beauty
Blurred lips, la tendenza labbra che ha conquistato anche Hollywood
Emma Stone, Kaia Gerber e Margaret Qualley sono solo alcune delle star pazze per il trucco che aumenta il volume della bocca in modo naturale (e senza gloss)
- fashion
5 look Anni ‘90 di Carolyn Bessette da copiare oggi
Dalla camicia bianca alla pencil skirt al cappotto sartoriale: 5 look timeless della moglie di John Fitzgerald Kennedy Jr.
- fashion
Nuove sfide della moda: cos'è il Millennial Optimism e perché potrebbe ridefinire il futuro della moda
Dalla fine dell’era dei grandi maestri a un’ondata di nuove nomine: con i numerosi cambi ai vertici delle maison, il sistema moda vive il più ampio passaggio generazionale degli ultimi anni
- living
Mangiare al museo: cinque indirizzi dove l’arte continua a tavola
Tra quadri, architetture iconiche e piatti d’autore, ecco i musei che oggi si visitano anche con il palato. Perché oggi l’arte non si guarda soltanto, si assapora con gusto
- X-STYLE PER NAJ OLEARI
Petalicious di Naj Oleari, Sanremo si tinge di rosa tra make up ed experience beauty
X-STYLE PER NAJ OLEARI
- fashion
Cappotto in primavera: i modelli e i colori per accogliere la bella stagione
Lungo o corto. Colorato, decorato o nelle nuances passe-partout, dal bianco al nero
- fashion
Tutte le sfumature dello scollo a barchetta e come abbinarlo
Dona ai capi un’allure elegante e slancia la figura. Lo scollo a barchetta torna come must-have dal sapore retrò: dagli abiti ai maglioni. Le linee amate da Audrey Hepburn conquistano le collezioni Primavera-Estate 2026.
- fashion
London Fashion Week FW2627: l’omaggio a Paul Costelloe, il designer che vestì Lady Diana
La sfilata che ha aperto simbolicamente la settimana della moda londinese si trasforma in un ideale passaggio dalla vecchia alla nuova guardia del fashion system
- entertainment
Eileen Gu vs Jutta Leerdam, la sfida olimpica tra sport, moda e follower
Medaglie, milioni di follower e brand globali: a Milano Cortina 2026 la sfida tra la sciatrice e la pattinatrice racconta due visioni opposte ma complementari dell’atleta contemporanea, tra lusso istituzionale e cultura pop digitale
- living
L’Italia in una tazzina: i caffè più amati e identitari
Dal Bicerin torinese al caffè del professore napoletano, passando per Trieste e Palermo
- Entertainment
Jacob Elordi: il villain romantico che riscrive le regole
Dal rapporto con la madre ai look che dialogano con il guardaroba femminile. L’Heathcliff di Emerald Fennell è il (non) eroe romantico del 2026
- entertainment
Cindy Crawford compie 60 anni. Perché la top model rimane un’icona degli Anni '90
Nei Nineties è tra le regine delle passerelle, rappresentante dello stile effortless nella vita quotidiana e pronta a sfoggiare abiti da red carpet. Cindy Crawford spegne 60 candeline, confermandosi simbolo di eleganza e stile, spesso accanto alla figlia Kaia. I suoi look, di ieri e di oggi, lo dimostrano
- entertainment
È lo sport il nuovo red carpet?
Non più solo competizione, ma linguaggio visivo, piattaforma culturale e nuova passerella globale
- Fashion
Sposa in tailleur: la tendenza bridal fa ritorno per la stagione dei matrimoni
Il tailleur bianco si conferma – per le spose di ieri e di oggi - il manifesto bridal più potente di sempre
- beauty
Come proteggersi dal sole, anche in montagna
I raggi sono onnipresenti, in città, al mare e anche sulla neve. Per preservare la salute e la bellezza della pelle si può ricorrere a formule intelligenti, leggere e facili da applicare (persino sugli sci)