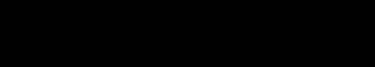Giornata mondiale della salute mentale: il sottile confine tra genio e follia
Nel giorno dedicato alla Giornata mondiale salute mentale, un viaggio tra filosofia, arte e neuroscienze per capire se davvero esiste un legame tra creatività e fragilitàC’è una linea sottile che separa la genialità dalla fragilità mentale. Una linea che attraversa secoli, discipline e miti culturali — e che torna al centro dell’attenzione proprio oggi, in occasione della Giornata mondiale della salute mentale.
“Perché tutti gli uomini straordinari sono malinconici?”
Si domandava, citando Aristotele, il saggista seicentesco Robert Burton nel suo L’anatomia della malinconia riprendendo uno dei temi, che sin dall’antica Grecia affascina filosofi, pensatori e ora anche le neuroscienze: esiste un rapporto tra genialità e disturbo mentale?
Una domanda che attraversa secoli e discipline, e che ancora oggi suscita fascino, inquietudine, e una certa dose di romanticismo.
Ma quanto c’è di vero, davvero, nell’idea che per essere creativi si debba essere anche un po’ folli?

Il mito antico del genio malinconico
Aristotele notava che molte personalità eminenti della sua epoca mostravano tratti di quella che chiamava melanconia: instabilità dell’umore, comportamenti imprevedibili, tendenze all'isolamento. Oggi gli scienziati riconducono molti di questi sintomi ai disturbi dell’umore, in particolare al disturbo bipolare, dove la creatività spesso si manifesta in fasi ipomaniacali, mentre l’umore può crollare repentinamente verso la depressione.
L’idea che la sofferenza psichica e l’ingegno possano coesistere non ha mai smesso di circolare. Seneca, nei suoi Dialoghi, scriveva che “non esiste ingegno senza un tocco di follia”.
Il rapporto tra genio e follia ha creato un’aura romantica attorno alle vite dei grandi artisti tormentati come Caravaggio, che nei suoi quadri ha raccontato le luci e le ombre profonde della sua vita spericolata ma anche piena di dolore. E durante il positivismo, Cesare Lombroso — padre della criminologia moderna — arrivò persino a tracciare un filo diretto tra genio, follia e devianza.
Ma attenzione: confondere la sofferenza mentale con il talento è pericoloso. Dietro il mito, c’è la realtà di una condizione di sofferenza.
Non è la malattia a creare l’arte, ma, in alcuni casi, può diventare parte del percorso di un’artista.

Quando la mente crea (e si rompe): i casi celebri
La lista degli artisti affetti da disturbi psichici è lunga. Van Gogh, affetto da crisi psicotiche e allucinazioni, trasforma il suo dolore in pittura. Il colore, la materia, la luce: tutto diventa mezzo per ordinare un caos interiore che non riesce a contenere. Edvard Munch, autore de L’urlo, dichiarò che senza l’angoscia e la malattia non sarebbe mai diventato artista.
Virginia Woolf che lottò per tutta la vita contro quella che lei definiva “follia” – e che ha raccontato nei suoi romanzi come Mrs Dalloway e nel saggio Sulla malattia - considerava la malattia, sia fisica che mentale, un'esperienza che alterava la percezione e poteva portare a una nuova comprensione della realtà, offrendo un punto di vista unico, distaccato dalla vita sociale "normale" e focalizzato sulla propria interiorità; Alda Merini, che definiva la follia come “una maggiore acutezza dei sensi”, ha trasformato la sua esperienza manicomiale in poesia.
La letteratura abbonda di esempi: Edgar Allan Poe, perseguitato da ossessioni e angosce; Leopardi, la cui ipersensibilità conviveva con una fragile salute mentale e fisica; Hemingway, Byron, Sylvia Plath che nel suo unico romanzo La campana di vetro ha raccontato la verità e la crudeltà delle cure psichiatriche negli anni ’50. In Italia c'è Cesare Pavese, il cui disagio esistenziale ha portato a romanzi straordinari ma anche ad una vita contrassegnata dalla fragilità e dalla solitudine.
L’elenco è lungo, e spesso ha esiti tragici per le vite degli artisti.
Nel campo della scienza, il caso forse più noto è John Nash, matematico e premio Nobel per l’economia, la cui vita con la schizofrenia paranoide è stata raccontata nel film A Beautiful Mind. Nash è l’esempio di come, nonostante la malattia — e non grazie a essa — si possa comunque generare bellezza, intelligenza, innovazione.

La lettura di Jaspers: genio e follia non sono la stessa cosa
È su questo punto che interviene una figura chiave del Novecento: Karl Jaspers, filosofo e psichiatra tedesco. Nel suo libro Genio e Follia – Strindberg e Van Gogh (1922, uscito in Italia con prefazione di Umberto Galimberti nel 1990) Jaspers introduce il concetto di patografia, ovvero l’analisi dell’opera artistica alla luce della storia clinica del suo autore.
Jaspers studia quattro figure emblematiche: Strindberg, Swedenborg, Hölderlin e Van Gogh, mostrando come in alcuni casi la malattia mentale abbia effettivamente influenzato la visione del mondo e lo stile creativo. Non è la malattia a “produrre” arte, ma il modo in cui l’artista riesce a trasformarla in espressione. In Van Gogh, ad esempio, non è la psicosi a generare i quadri, ma la sua capacità di restare aggrappato al pennello anche durante i momenti più difficili. È la volontà di dare forma al disordine, non il disordine stesso.
Cosa ci dice oggi la scienza?
Le neuroscienze moderne hanno cominciato a studiare questi fenomeni da vicino. Alcuni ricercatori, come James Fallon, hanno osservato somiglianze tra la fase “ipomaniacale” del disturbo bipolare e l’attivazione cerebrale che avviene durante momenti creativi intensi. La dopamina, neurotrasmettitore legato al piacere e alla ricompensa, è coinvolta sia nella creatività che nelle fasi maniacali.
Studi epidemiologici condotti in Islanda (Kari Stefansson) e in Svezia (Karolinska Institute) mostrano che le varianti genetiche associate a disturbi psichiatrici sono più comuni in famiglie di artisti: scrittori, musicisti, ballerini. Una correlazione che lascia intuire radici condivise tra vulnerabilità e talento, anche se il confine tra predisposizione e patologia resta sottile.
Importante sottolineare che la forma più grave di malattia mentale, spesso, limita la creatività. È nei casi più lievi, in quei tratti borderline, che si osserva la possibilità di pensare fuori dagli schemi.

Romanzi contemporanei per combattere lo stigma
La letteratura contemporanea spesso si interfaccia con il tema della salute mentale, raccontando il disagio non come etichetta, ma come esperienza di vita.
In Follia (1996) di Patrick McGrath, recentemente riscoperto grazie al passaparola sui social, la psicosi si intreccia con una passione estrema e distruttiva. Ambientato in un ospedale psichiatrico, il romanzo mostra da vicino i confini labili tra amore, ossessione e delirio.
Nel bestseller Il mio anno di riposo e oblio di Ottessa Moshfegh, una giovane donna borghese sceglie di spegnere la coscienza con psicofarmaci, tentando di uscire dal rumore e dalla pressione sociale attraverso l’autosospensione. È un libro spietato e ironico sul malessere contemporaneo, e sul confine tra apatia e ribellione.
Con Tutto chiede salvezza, Premio Strega Giovani, Daniele Mencarelli – diventato anche una serie televisiva di successo- accompagna invece dentro un reparto psichiatrico, dopo un TSO subito a vent’anni. La sua voce poetica e disarmata ci parla della fragilità come condizione umana universale.
Pensare fuori dagli schemi…
Come scriveva ancora Jaspers, ci sono artisti che, in mezzo alla crisi, riescono a cogliere “una fonte ultima dell’esistenza”, un momento in cui il dolore si trasforma in visione. È un’eccezione, non una regola.
Non serve essere folli per essere creativi, ma forse serve una certa elasticità mentale, una tolleranza all’ambiguità, una capacità di esplorare territori inesplorati — anche interiori.
Pensare in modo creativo significa spesso semplicemente non avere paura di essere un po’ strani, di non seguire le regole. Di lasciarsi andare ai propri sentimenti e di percorrere strade inaspettate, soprattutto nei confronti della percezione di sé. E di quello che la società spesso presenta come “giusto”.
In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, ricordare il confine tra genio e follia significa anche superare lo stigma che circonda la sofferenza psichica. Non è la malattia a generare arte o intelligenza, ma la capacità di trasformare la vulnerabilità in consapevolezza, e il dolore in linguaggio.
Ricordandoci che, citando la celeberrima frase di Franco Basaglia, “Da vicino nessuno è normale”.
Leggi anche:
Contenuti consigliati
- beauty
Bellezza ad alta quota: 4 trattamenti corpo da provare
Bagni di vapore, erbe aromatiche e neve: l’essenza della montagna si trasforma in rituali di benessere che rigenerano mente e corpo
- lifestyle
Grandi hotel e cavalli: binomio perfetto per soggiorni da sogno
Trascorrere del tempo in questi luoghi significa collezionare esperienze e ricordi indimenticabili
- beauty
Blurred lips, la tendenza labbra che ha conquistato anche Hollywood
Emma Stone, Kaia Gerber e Margaret Qualley sono solo alcune delle star pazze per il trucco che aumenta il volume della bocca in modo naturale (e senza gloss)
- fashion
5 look Anni ‘90 di Carolyn Bessette da copiare oggi
Dalla camicia bianca alla pencil skirt al cappotto sartoriale: 5 look timeless della moglie di John Fitzgerald Kennedy Jr.
- fashion
Nuove sfide della moda: cos'è il Millennial Optimism e perché potrebbe ridefinire il futuro della moda
Dalla fine dell’era dei grandi maestri a un’ondata di nuove nomine: con i numerosi cambi ai vertici delle maison, il sistema moda vive il più ampio passaggio generazionale degli ultimi anni
- living
Mangiare al museo: cinque indirizzi dove l’arte continua a tavola
Tra quadri, architetture iconiche e piatti d’autore, ecco i musei che oggi si visitano anche con il palato. Perché oggi l’arte non si guarda soltanto, si assapora con gusto
- X-STYLE PER NAJ OLEARI
Petalicious di Naj Oleari, Sanremo si tinge di rosa tra make up ed experience beauty
X-STYLE PER NAJ OLEARI
- fashion
Cappotto in primavera: i modelli e i colori per accogliere la bella stagione
Lungo o corto. Colorato, decorato o nelle nuances passe-partout, dal bianco al nero
- fashion
Tutte le sfumature dello scollo a barchetta e come abbinarlo
Dona ai capi un’allure elegante e slancia la figura. Lo scollo a barchetta torna come must-have dal sapore retrò: dagli abiti ai maglioni. Le linee amate da Audrey Hepburn conquistano le collezioni Primavera-Estate 2026.
- fashion
London Fashion Week FW2627: l’omaggio a Paul Costelloe, il designer che vestì Lady Diana
La sfilata che ha aperto simbolicamente la settimana della moda londinese si trasforma in un ideale passaggio dalla vecchia alla nuova guardia del fashion system
- entertainment
Eileen Gu vs Jutta Leerdam, la sfida olimpica tra sport, moda e follower
Medaglie, milioni di follower e brand globali: a Milano Cortina 2026 la sfida tra la sciatrice e la pattinatrice racconta due visioni opposte ma complementari dell’atleta contemporanea, tra lusso istituzionale e cultura pop digitale
- living
L’Italia in una tazzina: i caffè più amati e identitari
Dal Bicerin torinese al caffè del professore napoletano, passando per Trieste e Palermo
- Entertainment
Jacob Elordi: il villain romantico che riscrive le regole
Dal rapporto con la madre ai look che dialogano con il guardaroba femminile. L’Heathcliff di Emerald Fennell è il (non) eroe romantico del 2026
- entertainment
Cindy Crawford compie 60 anni. Perché la top model rimane un’icona degli Anni '90
Nei Nineties è tra le regine delle passerelle, rappresentante dello stile effortless nella vita quotidiana e pronta a sfoggiare abiti da red carpet. Cindy Crawford spegne 60 candeline, confermandosi simbolo di eleganza e stile, spesso accanto alla figlia Kaia. I suoi look, di ieri e di oggi, lo dimostrano
- entertainment
È lo sport il nuovo red carpet?
Non più solo competizione, ma linguaggio visivo, piattaforma culturale e nuova passerella globale
- Fashion
Sposa in tailleur: la tendenza bridal fa ritorno per la stagione dei matrimoni
Il tailleur bianco si conferma – per le spose di ieri e di oggi - il manifesto bridal più potente di sempre
- beauty
Come proteggersi dal sole, anche in montagna
I raggi sono onnipresenti, in città, al mare e anche sulla neve. Per preservare la salute e la bellezza della pelle si può ricorrere a formule intelligenti, leggere e facili da applicare (persino sugli sci)
- entertainment
Carnevale nei film: 5 titoli per celebrare la maschera e il doppio
Il cinema ha saputo spesso raccontare che l'identità non è un dato fisso, ma una scelta, una performance
- fashion
Marrone “is the new black”. La tinta terrosa che piace a star e principesse
È il colore che ha dominato la stagione fredda e che si conferma il preferito dalle dive
- living
Carnevale, ma d’autore: i dolci imperdibili riletti dagli chef
Chiacchiere, castagnole, frittelle e ravioli dolci tra memoria e innovazione: quando la tradizione incontra la firma dei grandi maestri della pasticceria italiana
- Fashion
Gonna e maglione, la combo chic che conquista passerelle e star
Gonne e maglioni, quando portati insieme, danno vita ad abbinamenti che non passano inosservati. Dai volumi ampi o più minuti. Ecco come abbinarli in 5 idee di stile
- living
Olympic ice: il design sale sul podio (e congela la casa)
Dalle vette di Cortina ai salotti di Milano, la nuova ossessione è l'arredo "sotto zero": una collezione da medaglia d'oro tra la forza bruta del cristallo e la grazia del grande ghiaccio. Il nuovo lusso è glaciale
- living
Che cosa sono i “bar segreti” e come trovarli
Non esiste una vetrina su strada: l'ingresso è nascosto e non sempre l’indirizzo è reso pubblico. In alcuni si entra attraverso una cabina telefonica, in altri da una cella frigorifera
- living
Capodanno cinese 2026: 5 indirizzi per festeggiare l’Anno del Cavallo di Fuoco
Dal 17 febbraio si apre l’Anno del Cavallo di Fuoco: tra riti beneauguranti, banchetti festivi e spettacoli tradizionali